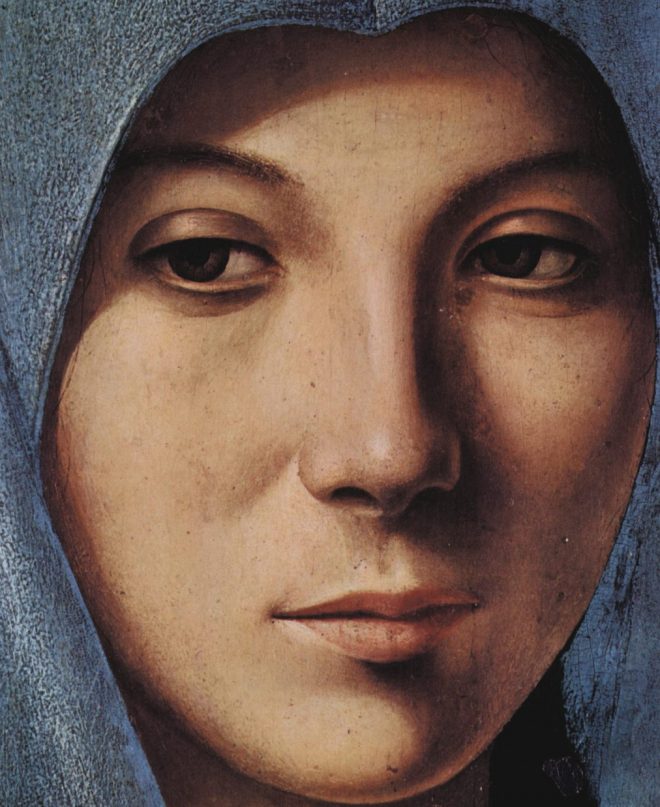Un libro e tre mandarini
A.D’Avenia – Relazione Convegno Univ 2015 – 31 marzo 2015 Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, che tanto vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia: di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri, molti dolori patì sul mare nell’animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Ma i compagni neanche così li salvò, pur volendo: con la loro empietà si perdettero, stolti, che mangiarono i buoi del Sole Iperione: ad essi egli tolse il dì del ritorno.
Racconta qualcosa anche a noi, o dea figlia di Zeus.
Quelle che avete appena ascoltato sono le parole iniziali dell’Odissea. Nell’originale greco la prima parola di questo poema è “uomo”, la seconda “narrami”. Il poeta chiede alla Musa di raccontare chi è l’uomo. Di darne una definizione narrativa. Ci vorranno ben 24 libri per rispondere a questa domanda, ma il poeta ci offre un rapido sommario iniziale. Da questa domanda: chi è l’uomo? dipende tutta la cultura occidentale. Chi è l’uomo? Il poeta ci dice che ha tre caratteristiche: conoscere città e pensieri o costumi di uomini, patire dolori, tutto al fine di acquistare a sé la vita e ai suoi compagni.
La poesia omerica sa dire solo l’essenziale: l’uomo è un viaggiatore, curioso conoscitore del mondo, che cerca di tornare a casa e per questo è chiamato a soffrire. Casa significa per lui “aver salva la vita”. Ma non vuole salvare solo la sua vita. Vuole salvare la sua vita e quella dei compagni. L’uomo, anér nel testo, viaggia, conosce, torna, patisce, tutto per cercare di salvare la sua vita (psyché) e il ritorno dei suoi compagni (etàiroi). Etàiros indica qualcuno con cui si condivide un ideale, un fine, un obiettivo. Lo traduciamo in italiano con compagno, in spagnolo con compañero, in inglese con companion. La radice di questa parola indica “qualcuno con cui si condivide il pane”: cum unito a panis, da cui compagno. L’identità di Ulisse, dell’eroe, è quella di un uomo che cerca di salvare la sua vita e quella dei suoi amici, dei suoi compagni. La sua identità è possibile proprio perché non è ripiegata su se stesso, ma proiettata verso l’altro, salvare sé e i compagni sono un’unica cosa. Dire Ulisse è dire allo stesso tempo: i suoi compagni, i suoi amici, la sua terra, la terra dei padri. Itaca.
Tutto questo ci è utile a rendere più visibile qualcosa che diamo per scontato, troppo scontato, proprio perché evidente: l’amicizia. Ci sono alcuni “dati di fatto” che essendo originari non hanno bisogno di essere spiegati: sono dati di partenza dell’umano. Oggi avvertiamo il bisogno di definire che cosa sia la famiglia, perché un concetto dato per evidente è diventato da “dimostrare”, ma non si possono dimostrare le cose originarie, proprio perché lo sono. Eppure la messa in discussione del concetto di famiglia ci sta obbligando ad un nuovo e più approfondito pensiero su questo dato di fatto originario. Lo stesso si potrebbe dire per l’amicizia. Non è sotto attacco o ridefinizione? Così pensiamo.
Se io vi dicessi che sto cercando di trovare nuovi amici e per farlo ogni giorno vado per strada urlando quello che ho cucinato, come mi sento, dove mi trovo, cosa sto facendo, mi scatto foto e le mostro a chi incontro, tocco la spalla di chi mi sta simpatico o mi attrae e dico “mi piace”… non starei forse definendo il mio concetto di amicizia? Non qualcuno con cui faccio un viaggio per cercare di salvarmi la vita e tornare a casa, non qualcuno con cui condivido lo stesso pane. No. Ma qualcuno da “aggiungere” su Facebook, qualcuno con cui salvare, non la vita, ma le apparenze, da cui essere ammirato, con cui condividere (share) non il pane, ma l’apparenza. Forse non ci sembra, ma anche il concetto di amicizia è in discussione, in modo più sottile forse, ma io ho 5000 amici su FB, e calcolando che in una vita gli amici degni di questo nome saranno una decina, non mi basterebbero 500 vite per avere veramente 5000 amici. Non voglio demonizzare i social network, che uso molto, ma guardare con attenzione i mutamenti che comportano nella nostra percezione ed esperienza del mondo. Non abbiamo amici, ma apparenze di amici, profili di amici. Ma amico, ci dice l’Odissea, è colui con cui condivido il pane, non l’apparenza, colui con il quale rischio la vita nel tentativo di realizzare qualcosa. La vita come dice un poeta “non è qualcosa, ma è per realizzare qualcosa”. Da soli? No. Insieme agli amici in carne e ossa, non insieme alle apparenze di amici, ai profili degli amici. Le apparenze di amici non sorridono, non piangono, non sudano, non puzzano, non masticano, non hanno un corpo, non mangiano pane, non si feriscono, non soffrono, non muoiono… Sono comodi da avere: non c’è bisogno di farsene carico o rischiare la vita per loro. Il massimo che riescono a condividere è un video, una fotografia, un mi piace. Ma la vita è ben altro. La vita è viaggio di ritorno a casa, in un mare pericoloso, nel quale si soffre e si ride molto, nel quale si conosce, nel quale si perde la rotta, nel quale ci si sente soli e abbandonati, se non fosse per un amico, con il quale si rema insieme, si progetta insieme, ci si dispera ed esalta insieme.
In un altro poema epico, antico forse più dell’Odissea, il protagonista, Gilgamesh, va alla ricerca della vita eterna perché il suo miglior amico, Enkidu, è morto e non sopporta che ciò possa accadere anche a lui: un amico non può sparire, essere inghiottito dalla morte, finire in un vago ricordo, in un sogno, in un’apparenza. Gli amici non sono profili, non sono apparenze. Gli amici ci ricordano che abbiamo bisogno della vita eterna, perché l’amicizia non può finire. L’amicizia è un dato originario, un bisogno originario, una scelta originaria. Non scegliamo l’amicizia, siamo scelti dalla e nella amicizia. Scegliamo gli amici, non l’amicizia. L’uomo è dato, affidato, all’altro uomo. È un dato originario e quanto più siamo originari tanto più saremo originali, perché gli amici ci costringono ad essere reali, ad essere noi stessi, a seguire la nostra identità, unicità, vocazione. Gli amici ci tirano fuori dalle apparenze, i veri amici ci danno realtà, non apparenza. Lo dice in modo perfetto uno scrittore del XX secolo: “L’amicizia è uno specchio in cui l’uomo si riflette. A volte, chiacchierando con un amico impari a conoscerti e comunichi con te stesso… Capita che l’amico sia una figura silente, che per suo tramite si riesca a parlare con se stessi, a ritrovare la gioia dentro di sé, in pensieri che divengono chiari e visibili grazie alla cassa di risonanza del cuore altrui.
L’amico è colui che ti perdona debolezze, difetti e vizi, che conosce e conferma la tua forza, il tuo talento, i tuoi meriti. E l’amico è colui che, pur volendoti bene, non ti nasconde le tue debolezze, i tuoi difetti, i tuoi vizi.
L’amicizia si fonda dunque sulla somiglianza, ma si manifesta nella diversità, nelle contraddizioni, nelle differenze. Nell’amicizia l’uomo cerca egoisticamente ciò che gli manca. E nell’amicizia tende a donare munificamente ciò che possiede”. Così scrive Vasilij Grossman, nel suo capolavoro Vita e destino, pp. 341-342)
E da dove viene questa intuizione di uno scrittore non credente? Dall’osservazione accurata della realtà dietro la quale c’è il progetto originario di Dio: l’uomo, Adamo, non trova nessuno “come lui” nel creato, allora Dio crea qualcuno capace di stare al suo fianco (è dal fianco che viene tratta la donna), ma prima di soffermarsi sul fatto che si tratta di una donna dobbiamo soffermarci sul fatto che l’uomo viene donato, affidato, affiancato all’altro uomo. L’uomo è fatto per la relazione. Solo relazionandosi al suo simile smette di sentirsi solo davanti al creato, solo nella relazione trova se stesso. E tutto questo viene prima, anche della relazione amorosa: l’amicizia è il fondamento di ogni relazione umana.
Giovanni Paolo II è modello di amicizia (consiglio di leggere la sua vita: andava in canoa con i suoi amici quando era sacerdote, remava con loro, per tutta la vita incontrava regolarmente i suoi amici: la mattina dell’attentato aveva incontrato il suo caro amico Lejeune, scienziato e Nobel per aver scoperto la causa della sindrome di Down, ha intrattenuto un carteggio bellissimo pubblicato da poco con una donna che era la sua più cara amica). La grandezza di quell’uomo, la sua santità, stava nella sua capacità di essere amico: dedicava tempo, lo sceglieva, non aveva apparenze di amici, ma amici reali a cui scriveva e con cui parlava, e che lo aiutavano ad essere reale, cioè santo. Se non avesse avuto quegli amici non sarebbe stato Giovanni Paolo II. Dio mette sul nostro cammino gli amici che ci aiuteranno ad essere reali e che aiuteremo ad essere reali. Infatti Giovanni Paolo II citava spesso questo passo della Gaudium et spes (n.24 – documento cardine del Concilio Vaticano II) “L’uomo, che è l’unica creatura che Dio ha voluto per se stessa, non può trovare se stesso pienamente senza un dono sincero di sé”. C’è qualcosa di originario e rivoluzionario in questa frase. L’uomo, l’uomo su cui si interrogava il poema dell’Odissea, chi è secondo la rivelazione cristiana? L’uomo è una creatura che ha capacità di determinare se stessa, essendo dotata di libertà – ad immagine e somiglianza di Dio – e per questo può amare, quest’uomo allo stesso tempo non può essere se stesso senza donarsi a qualcun altro. L’uomo è in questo senso autonomo e non autonomo allo stesso tempo. É senza gli altri, perché è unico, irripetibile, solo, insostituibile, ma non può essere se stesso senza gli altri, senza donarsi ed essere donato agli altri.
Non è un caso che impariamo a dire “tu” prima che “io”. Il poeta spagnolo Pedro Salinas scriveva “Possesso di me tu mi davi, dandoti a me”. Solo se qualcuno si dà a noi, amandoci, noi possiamo avere possesso di noi stessi, presa su noi stessi, conoscenza di noi stessi. Il bambino impara ad essere un “io” grazie all’amore della madre e del padre. Allo stesso tempo solo se noi ci diamo a qualcuno amandolo, possiamo aiutare l’altro ad essere se stesso e noi ad essere noi stessi. Sempre lo stesso poeta scriveva “Scusami se nel mio modo di amarti ti faccio soffrire, ma è che da te voglio estrarre il tuo migliore tu”. Alla fine della vita ci sarà dato un sassolino bianco, dice l’Apocalisse, con scritto il nostro vero nome, non sarà altro che il compimento visibile, evidente, di quello che sta già accadendo adesso, in questo momento (Apocalisse vuol dire rivelazione, non oroscopo…): tutta la realtà è il set che Dio ha costruito perché diventiamo pienamente noi stessi. Solo allora, al momento dell’Apocalisse, ci renderemo conto di quanto aveva fatto per realizzare la pienezza di noi, il suo progetto originario, come dice a Geremia, quando il giovane si lamenta di non essere all’altezza di fare il profeta: “Geremia, ma io ti conoscevo prima che tu entrassi nel grembo di tua madre”. Dio è il garante e custode del nostro destino di felicità: noi scegliamo se volerlo o no. Gli amici (cioè le relazioni) sono la strada perché questo accada, nel ricevere e nel dare.
Ecco l’amicizia, la relazione primaria, un continuo viaggio di andata e ritorno, di amore dato e ricevuto, a quelle persone che il viaggio della vita mi ha messo accanto. Senza i quali è minacciata la vita eterna (come dice Gilgamesh) perché la vita eterna è il raggiungimento della pienezza di sé, la piena realizzazione di sé, la piena maturazione del dono di sé. L’amicizia è la strada attraverso cui tutto questo si compie. Non può essere un caso che spesso i comici vadano in coppia: non ci può essere Stanlio senza Ollio. Ciascuno per essere se stesso ha bisogno degli amici: cosa ne sarebbe del Signore degli Anelli e delle Cronache di Narnia se Tolkien e Lewis non avessero creato un gruppo di amici, gli Inklings, che si trovavano a bere birra (a volte il pane non basta…) e leggere le loro storie a vicenda, dandosi consigli, migliorandole, facendole a pezzi.
Nella realtà tutto è relazione, perché viene da una relazione originaria, la Trinità. Guardate questo bicchiere d’acqua: è una relazione. La relazione tra due atomi di idrogeno e uno di ossigeno: ciascuno dà all’altro quello di cui l’altro ha bisogno per essere una cosa nuova, più grande, più piena. Presi singolarmente, l’idrogeno e l’ossigeno, esistono e hanno la loro dignità, ma messi insieme, in quelle proporzioni, sono la ragione della vita su questo pianeta. Non andiamo forse a caccia di tracce d’acqua su altri pianeti per sperare ci sia la vita?
L’amicizia è la relazione principale e originaria, perché permette alla realtà di essere secondo il piano di Dio, permette all’amore di avere luogo nel mondo e di edificarlo secondo l’amore originario.
La mia libertà non finisce dove comincia quella di un altro: secondo la rivelazione cristiana è l’opposto. La mia libertà, la possibilità di realizzare pienamente me stesso, comincia proprio dove incontro la libertà dell’altro: unità nella differenza. Non sto parlando di facili irenismi e pacifismi, ma proprio dell’impegno per dare all’altro quello di cui ha bisogno e per ricevere dall’altro quello di cui io ho bisogno. La società nasce dalla scarsità di beni: siamo costretti a cercare l’unità nella differenza, in modo che i talenti circolino “liberamente” tra gli uomini. Solo così l’amicizia si amplia e diventa fondamento dell’intera società. L’amicizia è il modello della cittadinanza, perché evita ogni sorta di utopistico contratto tra monadi che si fanno la guerra tra loro. L’amicizia è salvare la vita propria e dell’altro, proprio nel dono di sé. Non si parte dalla paura dell’altro ma dall’impegno per dare ampliare una relazione che rende le differenze ancora più specifiche e per questo arricchenti proprio grazie alla relazione (termine che viene da re-fero: portare qualcosa più e più volte a qualcuno). Non si tratta di “distinguere per unire” artificiosamente, ma di cercare l’unità mantenendo le differenze. Per questo San Paolo può scrivere ai Corinzi (1 Cor 8,1) che la “carità edifica”, non nel senso moralistico che gli abbiamo dato, come se si trattasse di dare il buon esempio, ma nel senso reale: solo l’amore che proviene da Dio e passa all’uomo che lo accetta, riceve e rivolge all’altro uomo, costruisce, appunto edifica il mondo nuovo di cui parla l’Apocalisse: “ecco io faccio nuove tutte le cose”. Si rinnova tutto, attraverso noi.
Lo conferma Benedetto XVI all’inizio dell’enciclica Caritas in veritate in cui sostiene che la carità è il fondamento delle micro-relazioni (amicizia, famiglia) e delle macro-relazioni (politica ed economia). La carità è il progetto originario di Dio, della Trinità, che consegna questo dono all’uomo, lo imprime nella sua identità, così che questo “amore” diventa un a-priori da cui partire per costruire tutte le relazioni: il nostro pregiudizio è l’amore. L’unico pregiudizio che possiamo avere, perché è la realtà stessa ad esser fatta così: ci è data come dono, noi siamo dati a noi stessi e agli altri come dono, il mondo ci è dato in dono. Quando San Josemaria parlava di amare il mondo appassionatamente non parlava di un programma morale, ma di un dato di fatto di partenza: solo l’amore appassionato alla realtà permette alla realtà di dispiegarsi, di essere se stessa, di compiersi, di fiorire. Solo se l’artista ama la sua ispirazione trasformerà pietra e colori in un’opera, solo se il contadino ama il seme e la terra potrà con il suo lavoro trasformarli in campo da mietere, solo se l’insegnante ama il suo alunno egli gli si aprirà per ricevere ciò di cui ha bisogno, solo se il punto di partenza è un amore appassionato (passione indica sia il trasporto erotico sia la sofferenza: è sia il trasporto della relazione sia la fatica della relazione) la realtà può essere e diventare se stessa. All’uomo dell’Eden è dato il compito di custodire e coltivare il giardino: proteggere e sviluppare.
Noi cristiani a volte appiattiamo la rivelazione a un programma morale, quando invece si tratta del movimento che Dio ha impresso nel mondo a partire dal suo fondamento, nel quale abbiamo il privilegio di essere inseriti. Solo chi si lascia catturare da questo movimento può portare la realtà a pieno compimento, la sua e quella degli altri. E trasformare la sua vita e quella dei suoi amici (tutti quelli che gli sono affidati e a cui si affida) in un capolavoro di Dio. E non solo quando le cose ci vanno bene, ma anche e soprattutto in situazioni di debolezza, di fatica, di abbandono, di solitudine, di malattia… con il coraggio di farsi carico delle situazioni dando e ricevendo ciò di cui c’è bisogno.
Cristo lo ha detto chiaramente: “Senza di me non potete fare nulla”. Sta parlando proprio di questo fondamento, senza il quale ogni nostra azione perde consistenza, diventa apparenza, un simulacro, magari accattivante, affascinante, ma senza il sapore della vita vera, della vita eterna, della vita che non muore.
Chi è l’uomo? Pilato quando mostra il Cristo flagellato che ricorderemo venerdì prossimo dice “Ecce homo: Ecco l’uomo”. Non è più l’eroe dell’Odissea, eppure anche lui ha conosciuto la città degli uomini e i loro pensieri, ha patito molto in questo viaggio dell’incarnazione. Ma a quale fine? Anche lui per salvare la vita dei suoi compagni, ma con una novità assoluta: rinunciando alla sua. Dice a chi lo uccide: “Non siete voi che mi togliete la vita, sono io che la dono” Quando è sulla croce lo scherniscono: “è stato capace di salvare gli altri, e non è capace di salvare se stesso”.
Ecco l’assoluta novità del cristianesimo. Noi possiamo donarci agli altri perché lui per primo si è donato del tutto. Possiamo realmente farlo se ci lasciamo conquistare dalla sua vita, se la lasciamo penetrare in noi. Ulisse si era salvato e i suoi compagni erano morti, nonostante i suoi tentativi. Erano periti perché avevano compiuto un sacrilegio: mangiare le vacche sacre del Sole. Cristo fa il contrario: rinuncia a salvare se stesso e salva noi, proprio perché ci siamo ribellati a suo Padre. Il vero uomo, il vero eroe, è sotto i nostri occhi: arriva a perdonare noi e donare sé pur di salvare i suoi compagni. Chiama gli apostoli amici: “vi ho chiamati amici perché vi ho raccontato le cose del Padre mio”. Quel racconto (anche Omero chiedeva alla Musa di raccontare l’uomo) della sua identità più profonda, essere Figlio e mostrare così il Padre, gli è costato la vita e ci salva. L’amicizia nella definizione di Cristo è proprio il dare ciò che ha di più proprio e di cui noi avevamo più bisogno: il Padre. Uno dei suoi, Filippo, gli dirà: “Mostraci il Padre e ci basta”. E si sentirà rispondere: “Chi vede me, vede il Padre”. Nella relazione ci dà quello di cui abbiamo bisogno: la filiazione al Padre, quello che Lui ha per essenza. Così ci salva, avendoci resi compagni, cioè amici con cui spezza il pane, alla stessa tavola (non è forse così che lo riconosceranno i due amici di Emmaus tristi dopo la sua morte?). Non solo quando è passato su questa terra, ma oggi, diventato lui stesso “pane” della compagnia.
Siamo il potenziale più pericoloso per il mondo, perché abbiamo una novità assoluta da portare. Chi vedeva i primi cristiani diceva “guarda come si vogliono bene”: la loro amicizia era evidente, era visibile, era già l’Apocalisse, per questo le persone erano attratte a Dio e da Dio, e si avvicinavano alla Chiesa primitiva. Per questo Nietzsche scrisse che si sarebbe convertito al cristianesimo il giorno in cui “avesse visto sul volto dei cristiani il volto dei redenti”. E perché non lo vide? Non volle vederlo o non incontrò nessuno capace di mostrarlo?
Chi ci guarda cosa vede?
Riesce a vedere la nostra amicizia?
Chi di noi darebbe la vita per i suoi 5000 amici su Facebook? E poi perché 5000 non l’ho ancora capito…
E cosa è questo dare la vita se non dedicare del tempo, quel tempo che una volta dato non torna più e quindi è come morire un poco. Sì, perché non c’è amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Vita reale a vite reali. Senza apparenze. Questo è il dono e il compito della nostra vita: ricevere amicizia da Dio per dare amicizia al mondo, amandolo appassionatamente, costi quel che costi. Chi ha passione deve anche patire, perché ha il cuore aperto e grande. Chi non ha passione spegne la vita, propria e altrui.
A volte può essere qualcosa di molto piccolo, un libro o anche tre mandarini. E con queste due storie che mi sono capitate recentemente vorrei concludere.
Mi ha scritto una ragazza che lavorava nel reparto di oncologia di un ospedale raccontandomi che ha conosciuto un ragazzo che faceva la chemioterapia, ma non aveva molte speranze. Ha deciso di comprare un libro e regalarglielo. Quel libro è un libro che ho scritto io, si intitola Ciò che inferno non è. Quel ragazzo è morto qualche settimana dopo. La madre del ragazzo ha restituito il libro a quella ragazza, dicendo che era giusto lo avesse lei. Quel libro aveva delle righe sottolineate e la madre del ragazzo nel darlo alla ragazza ha detto che quel libro gli aveva dato speranza, anche quando non ce n’era più. In questa storia ciascuno ha fatto ciò che poteva per l’altro, sempre con un di più rispetto al dovuto. Così la morte è stata trasformata in un momento meno duro, meno amaro, forse addirittura un momento di speranza.
L’altro giorno tornavo a casa, pioveva, avevo fretta, come tutti alla fine di una giornata di lavoro. Guardavo lo schermo del mio smartphone, come molti altri. Sulla strada c’era una signora prostrata a chiedere l’elemosina. Alcuni non se ne accorgevano, presi dal loro telefono, altri la scansavano, altri la guardavano senza fare nulla. Ad un tratto un’altra donna è uscita dal negozio dove aveva comprato la frutta, tra me e quella mendicante, per questo ho assistito alla scena, si è chinata, ha preso tre mandarini dalla sua spesa e le ha detto “Questi li mangi lei, non li dia ai cattivi”. In quel libro, in quei mandarini ho visto l’amicizia di Dio per e tra gli uomini. Realmente.
Le apparenze erano svanite. E a tutti è venuta voglia, su quella strada, su ogni strada del mondo, di essere più reali. Cioè più amici.